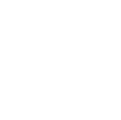Settimana Santa 2025
«Strappa il velo di questo dolce incontro»
Messa In Coena Domini
Chiesa Cattedrale – 17 aprile 2025
Omelia
«Bisogna macinare a lungo le parole e morire in silenzio per far cuocere il pane del cielo»
(C. Bobin, Il Cristo dei papaveri, Frammento LXX).
Come abbiamo pregato nella Colletta iniziale, è Dio Padre, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il suo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò ai suoi discepoli e alle sue discepole – alla Chiesa – il nuovo ed eterno sacrificio, il convito nuziale del suo amore, perché dalla partecipazione a così grande mistero ne attingano pienezza di carità e di vita.
Paolo, nella trasmissione ai Corinti di quello che ha ricevuto dal Signore (cfr 1Cor 11,23), lega la memoria dell’ultima cena – in particolare il segno posto da Gesù del pane spezzato e del calice del vino condivisi – alla morte in croce, cioè al dono di sé che Cristo fa, amando i suoi fino alla fine, fino al massimo, «fino al compimento (eis télos)» (Gv 13,1): «Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga» (1Cor 11,26).
Stasera, la Messa in Coena Domini, ci ammaestra particolarmente su questo intrinseco legame che mai deve essere disgiunto: l’eucarestia senza la croce, senza il dono della vita di Cristo, senza questo suo ‘eccesso d’amore’, si riduce a mera ritualità formale che non ‘pro-voca’, non parla alla vita. Ma l’eucaristia, d’altra parte, rivela il significato della croce. È l’interpretazione autentica, l’ermeneutica della morte di Cristo, come lo è anche la lavanda dei piedi. La morte in croce di Gesù senza l’eucarestia e la lavanda dei piedi – i due gesti posti e ‘istituiti’ da Gesù in quell’ultima cena – rimarrebbe solamente un fatto ordinario della storia umana: l’eliminazione degli innocenti e dei giusti. Quanti innocenti e giusti anche oggi vengono crocifissi! L’eucarestia e la lavanda dei piedi sono la nitida spiegazione della «parola della croce», della «pazzia (moría)» (1Cor 1,18) della croce, dell’amore estremo di Dio per noi uomini. Due segni profetici che gettano luce su quel fatto scandaloso della croce e ne narrano il senso più profondo. In forza di questo estremo gesto d’amore di Cristo, l’eucarestia non sarà mai e non potrà mai essere un mero rito formale. Ma il rischio è sempre accovacciato sull’uscio delle nostre comunità. Come accadeva a Corinto.
Si tratta di ‘entrare nell’eucaristia’, per partecipare di ciò che “rappresenta”, di ciò che “ripresenta”. Essa non va solamente celebrata, ma com-presa, cioè presa-con-noi, così da prendere dimora in noi. Nel pane e nel vino santificati dallo Spirito ci raggiunge la charitas sine modo, l’amore ‘eccessivo’ di Dio per noi in Cristo, così da divenire cibo e bevanda sostanziali di vita e di fraternità, fino all’eccesso del dono di sé per altri.
«Bisogna macinare a lungo le parole e morire in silenzio per far cuocere il pane del cielo», leggiamo in un frammento di C. Bobin. Pane del cielo impastato di terra. Occorre assimilare nel silenzio i gesti eucaristici di Gesù. L’Eucaristia ci fa leggere la vita, e le relazioni a partire da Dio e dal suo amore. Immette in noi – in quanti la celebriamo «arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi, perché il Signore ha voluto così», cantavamo nel dopo-Concilio con M. Giombini – la potenza stessa della relazionalità ‘cristica’. La celebriamo per dirgli grazie di tanto amore e perché la nostra comunione al suo Corpo e al suo Sangue ci performi ‘cristicamente’; perché il Signore ci faccia entrare sempre di più nel mistero della sua vita donata per noi. E ci renda un unico Corpo, capaci di far morire in noi l’io bramoso e ogni forma di idolatria mondana che inquina le relazioni umane, sociali, familiari ed ecclesiali; semina odio, inimicizia, divisione, indifferenza, competizione, violenza; genera scarti umani, guerre, morte e distruzione.
Il gesto della lavanda dei piedi, registrato dal IV Vangelo durante la cena, è inusuale poiché veniva praticata ritualmente all’inizio del pasto. Un gesto così, disturba oltremodo. Come inquieta e suscita scandalo la croce di Gesù. Semina disagio. Questa prestazione da schiavo, mentre è in atto il pasto, sconvolge drammaticamente la visione che i discepoli avevano del Maestro. Gesù pone un segno enigmatico, una parola profetica e rivelativa di tutta la sua vita e, in particolare, della sua ormai imminente morte. «C’è in questo enigma il senso della sua incarnazione – vita, passione, morte, risurrezione – e quindi anche il senso dell’eucarestia: Gesù si mette a nostra totale disposizione, nelle nostre mani, anche come nostro nutrimento per essere il Dio tra noi, con noi e per noi» (C. M. Martini, I Vangeli, 980-981). Il suo non è un semplice atto di umile servizio. Gesù ci vuole introdurre alla comprensione di tutta la sua esistenza e alla ‘forma’ della sua messianicità: la forma di servo (cfr Fil 2,5-11). Una postura umana che rivela la postura divina. Nella lavanda dei piedi viene svelato definitivamente il vero volto di Dio: «Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18).
Un gesto che narra non solo quello che Gesù ha fatto, ma ciò che Dio è, la sua logica e, soprattutto, la relazione che pone con noi esseri umani. Dio amante degli uomini. Dio servitore degli uomini. Gesù “esiste per altri”, esclusivamente. «L’“esserci-per-altri” di Gesù» (D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, 462).
Ed è qui che noi discepoli e discepole di Cristo troviamo il senso ultimo dell’esistenza umana, la ragione ultima delle cose. Delle nostre comunità. Essere, esistere per altri, perché altri abbiano vita in abbondanza. Ci realizziamo ‘essendoci-per-altri’. Amando! Solo se amiamo sforniamo e condividiamo il pane essenziale per la vita del mondo. Solo se si ama costruiamo. Vinciamo il peccato, l’odio, l’egoismo, la divisione, i conflitti (anche quelli armati) e la morte. Solo amando.
L’esempio che ci dà Gesù – «vi ho dato, infatti, un esempio» – è quello di tutta una ‘vita da servitori’, pensata come dono di sé che manifesta l’amore di Dio: «perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). Ma accettare una tale manifestazione del volto, dell’essere di Dio, è difficile. Depista e scandalizza. La figura di Giuda dice l’incredulità che si chiude alla rivelazione dell’amore di Dio. A Pietro invece risulta ostico accettare una tale umiliazione di Gesù. Per l’ennesima volta, vuole dettare lui i criteri, come aveva fatto a Cesarea di Filippo, scandalizzato dalla predizione della morte di Gesù: «cominciò a protestare dicendo: “Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai”» (Mt 16,22). Qui si irrita e si ribella: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!» (Gv 13,8). Come si fa ad accettare come misura della vita decentrarsi per essere capaci di «un amore più grande» (Gv 15,13)? Ma discepolo è chi accetta di essere coinvolto nel destino di Gesù. Senza questa postura esistenziale non ci può essere comunione con lui: «Se non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13,8).
Questo è l’amore che alimenta in noi l’eucaristia. La si può celebrare solamente così. Gesù non ci ha consegnato un gesto rituale, bensì il memoriale di «un amore più grande» che l’eucaristia alimenta i noi: «Fate questo in memoria di me» (1Cor 11,24). Senza questa consapevolezza si diventa religiosi increduli o cristiani scandalizzati di Cristo, della sua logica, del suo modo di amare, di donarsi, di dare lode a Dio nella consegna di tutta la sua vita. E, ahimè, inclini a far propria la logica mondana.
La memoria della Cena del Signore – particolarmente stasera – ci doni comunione con lui. Nessuno di noi si scandalizzi, anzi affrettiamoci a porgere – senza resistenza alcuna e con fiducia – i nostri piedi a Gesù, Maestro e Signore della nostra vita. Facciamoci lavare i piedi. Così da essere totalmente liberi da noi stessi e dal nostro orgoglio e appartenere solamente a Dio. Tutto dobbiamo a lui, al suo amore smisurato che vuole ancora traboccare in noi e attraverso noi raggiungere altri: «perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15).
Si tratta di essere e di fare come Gesù. Fare come lui. Ecco da dove sgorga il fare dei cristiani. Dove si nutre la loro gioiosa speranza: «Beati voi se, comprendendo (oídate) queste cose, le fate (poiēte)» (Gv 13,17). «Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro» (Lc 6,40). Dalla meraviglia e dalla contemplazione di tanto amore riversato da Dio nella Pasqua del suo Figlio nasce il fare di noi cristiani. Essi fanno secondo l’essere e il fare di Dio rivelatoci nella croce del suo Figlio, nella sua morte e risurrezione. Per questo obbediamo al suo mandato di fare memoria della sua cena nell’eucaristia: «Fate questo in memoria di me» (1Cor 11,24; cfr Lc 22,19). Il cristianesimo, il discepolato cristiano ci ‘eucaristizza’: impianta in noi la totale e radicale disponibilità per gli altri. Perché abbiamo ‘com-preso’ (‘preso con noi’) l’amore di Dio in Cristo Gesù per noi! Questo è il mistero della fede che contempliamo nella celebrazione eucaristica: «Annunciamo la tua morte Signore, proclamato la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta» (Acclamazione, dopo la consacrazione). Ogni Eucaristia impianta in noi il fare di Cristo, secondo Cristo e la sua misura relazionale: capaci in lui di un amore più grande. Da questo conosceranno la nostra gioia di appartenere al Signore, che siamo suoi discepoli (cfr Gv 13,35).