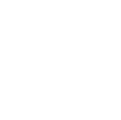La notizia che non più solo la Chiesa (che lo fa da tempo), ma anche i sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno preso posizione contro l’apertura dei negozi a Pasqua e, più in generale, nei giorni festivi, rivendicando il «valore sociale» della festa, meriterebbe un momento di riflessione collettiva che invece, purtroppo, probabilmente non ci sarà. Divisi tra le vicende della politica e quelle della cronaca rosa e nera, i mass media e l’opinione pubblica tendono a relegare ai margini fatti come questi, dove si giocano tendenze di fondo del costume, attraverso cui però si viene plasmando la nostra dimensione umana.
La notizia che non più solo la Chiesa (che lo fa da tempo), ma anche i sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno preso posizione contro l’apertura dei negozi a Pasqua e, più in generale, nei giorni festivi, rivendicando il «valore sociale» della festa, meriterebbe un momento di riflessione collettiva che invece, purtroppo, probabilmente non ci sarà. Divisi tra le vicende della politica e quelle della cronaca rosa e nera, i mass media e l’opinione pubblica tendono a relegare ai margini fatti come questi, dove si giocano tendenze di fondo del costume, attraverso cui però si viene plasmando la nostra dimensione umana.
Perché ciò di cui si tratta, qui, è il peso che la logica del mercato deve avere nella nostra vita personale e collettiva. E su questa valutazione pesano alcune delle pregiudiziali più radicate, oggi, prima fra tutte quella secondo cui è giusto che ognuno sia libero di fare quello che vuole, purché non invada la sfera altrui. Quante volte abbiamo ripetuto e sentito ripetere la formula magica: “la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”!
E a questa formula si è ispirata la liberalizzazione operata dal governo Monti, che ha autorizzato l’apertura degli esercizi commerciali nelle domeniche e nei giorni festivi. Non un obbligo, naturalmente, ma un diritto. Ognuno faccia quello che ritiene meglio. La stessa logica che da molti anni ispira tante battaglie per i “diritti civili”, dal divorzio, all’aborto, alla fecondazione assistita, al testamento biologico.
Ma proprio il caso della “libertà” di tenere il proprio esercizio commerciale aperto nelle festività rivela con particolare evidenza la problematicità del principio generale, così spesso invocato come ovvio. Perché fa toccare con mano che in realtà ogni nostra scelta, anche quelle che apparentemente riguardano solo noi, condizionano la vita degli altri, cosicché la nostra libertà, ben lungi dal finire dove comincia la loro, fin dall’inizio si intreccia indissolubilmente con essa.
Così, nel caso dell’apertura dei negozi nei giorni festivi, si può ben dire che nessuno costringe un commerciante a rinunziare al riposo domenicale. Ma si dà il caso che, se gli altri aprono, anche lui di fatto sia obbligato dalla logica della concorrenza a fare lo stesso, se non vuole perdere i già rari clienti. Per non parlare dei commessi, anch’essi perfettamente liberi, a termine di legge, di rifiutarsi di trascorrere il giorno di Pasqua lavorando. Salvo a rischiare, così facendo, di rientrare nella “lista nera” degli impiegati da congedare alla prima occasione. E, nel nuovo regime della “flessibilità (anch’esso propugnato in nome della libertà!), di occasioni non ne mancano certo…
La sproporzione di forze tra la libertà dei forti e la “libertà” dei deboli è ancora più evidente se si prende atto che ormai a dominare la scena del mercato sono i mega-centri commerciali, rispetto alle cui scelte la volontà del singolo commesso o della singola commessa conta meno di zero. Il datore di lavoro non ha bisogno di violare la libertà dei suoi dipendenti, che formalmente resta piena. Però nella sostanza la scelta che essi sono chiamati “liberamente” a fare si svolge nei termini di una famosa pubblicità di alcuni anni fa: “O così o pomì”.
Siamo davanti all’equivoco di fondo del liberismo economico, che ha sempre posto i protagonisti della vita sociale sul piano di una immaginaria parità, garantendo a ognuno di essi gli stessi diritti e sostenendo che, lasciando ad essi il diritto di perseguire il proprio interesse individuale, una “mano invisibile” avrebbe sempre, alla fine, garantito un risultato positivo per tutti. È stato così che, nella prima rivoluzione industriale, i proprietari delle fabbriche stabilivano “liberamente” livelli di salario sufficienti solo a non far morire di fame gli operai, e questi, altrettanto “liberamente” decidevano di accettarli, per dar qualcosa da mangiare ai loro figli. Gli storici dicono che la “mano invisibile” si è rivelata, così, benefica per lo sviluppo del capitalismo, ma meno generosa nei confronti delle masse di sventurati che ne hanno dovuto pagare il prezzo con una vita ai limiti dell’umano.
Nel corso degli ultimi due secoli lo sviluppo dei diritti sociali ha sempre più imposto dei limiti a questa logica perversa, anche sotto la pressione dei movimenti socialisti e – in misura minore, anche se significativa – della dottrina sociale della Chiesa. Ma, ora che da una parte la crisi del socialismo (peraltro responsabile, sotto altri profili, delle forme politiche totalitarie che in suo nome sono state instaurate nella prima metà del secolo scorso), dall’altra l’irrilevanza dei cattolici sulla scena pubblica, sembrano aver consacrato l’indiscussa egemonia del neo-capitalismo, molte conquiste dei lavoratori sono state rimesse in discussione dalla logica stessa del mercato.
Ed è alla luce di questa logica – presentata da finanzieri, banchieri, grandi industriali come indiscutibile – che si è attuato in questi anni un ritorno alla liberalizzazione selvaggia, in cui rientra anche l’apertura indiscriminata dei negozi. Un ritorno mascherato da esigenza “naturale” e in definitiva benefica per tutti (la “mano invisibile”!), ma che in realtà corrisponde al trionfo dell’ideologia liberale portata all’estremo, l’unica sopravvissuta alla morte delle altre, forse anche perché così potente da far credere di non essere altro che la realtà delle cose.
Si potrà dire che almeno per i consumatori l’apertura dei negozi a Pasqua e nelle domeniche è un’opportunità. Anche se, a cercare il pelo nell’uovo, ormai in moltissimi casi la “settimana corta” consente di fare acquisti, volendo, anche il sabato… Ma in realtà il problema non è quello del tempo materiale in cui fare shopping, bensì il valore simbolico che questo ha assunto nella nostra società. Ormai per molte famigliole il modo migliore di celebrare la domenica e le altre festività non è più di andare a messa, o di fare una gita in campagna, come si usava una volta, ma di recarsi in un centro commerciale dove trascorrere la giornata, trovandovi ognuno – papà e mamma per un verso, i figli per l’altro – qualcosa che solletichi il desiderio e che si possa consumare o comprare. Al punto che in alcune diocesi italiane si è ritenuto opportuno celebrare là anche la messa domenicale… Salvo a chiedersi se, ridotta a un consumo tra gli altri, anche l’esperienza cristiana non rischi di essere solo una ciliegina sulla torta dell’unica vera religione dominante, quella del consumismo.
Molto più del tentativo di rimuovere i crocifissi dai luoghi pubblici, è questa forse la minaccia più reale che la secolarizzazione sta producendo nei confronti della fede. Perché essa, per non ridursi a una pratica esteriore, ha bisogno di tempi di “riposo dell’anima”, di calma, di silenzio, di riflessione. Ma, al di là dell’essere o no credenti, tutti gli esseri umani hanno diritto a questo spazio interiore, necessario per conservare e sviluppare la propria umanità in una società dominata da ritmi frenetici e stressanti. Tutta la settimana ne è segnata, con la sola possibile oasi di pace rappresentata dalla festa. Necessaria, non solo per ritemprare le forze del singolo (per questo potrebbe bastare anche il tempo libero garantito in altri giorni), ma per vivere in famiglia, con amici, con la comunità tutta, una condivisione di valori umani, religiosi e civili che danno senso al proprio lavoro negli altri sei giorni.
La richiesta di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi – con le dovute eccezioni, studiate caso per caso, là dove siano in gioco dei servizi necessari – esprime questa esigenza. A molti essa apparirà meno reale di un possibile aumento di mezzo punto del nostro Pil. E non c’è da stupirsene, perché il mercato neo-capitalistico ci sta plasmando secondo le sue logiche. Ma proprio da questa dolorosa constatazione può uscire rafforzato il grido di protesta di quanti ancora hanno la lucidità e il coraggio di ribellarsi. Forse l’ultimo atto che ci rimane di vera libertà.