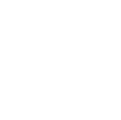Opposti fronti
Opposti fronti
La sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito ha suscitato opposte reazioni.
Da una parte lo «sconcerto» della Conferenza Episcopale Italiana, che, citando papa Francesco, vede nella sentenza un cedimento alla «tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato».
Dall’altro l’esultanza di Marco Cappato, che si era autodenunciato per aver assistito DJ Fabo nel suo proposito suicida, che ha commentato: «Ora siamo tutti più liberi».
Una polemica futile
Al margine dello scontro, che in realtà coinvolge due ampi settori dell’opinione pubblica, c’è la polemica da parte di alcuni giornali che avevano sostenuto il governo precedente – «I giudici si trasformano in legislatori» («La Verità»), «La Corte decide al posto del Parlamento» («Il Giornale») –, i quali accusano la Suprema Corte di aver voluto sostituirsi, “senza essere stati eletti da nessuno”, ai rappresentanti del popolo.
Una polemica che liquidiamo subito per la sua evidente pretestuosità.
Infatti, già un anno fa la Consulta aveva chiesto al Parlamento una legislazione che regolamentasse la delicata materia, sostituendo l’art. 580 prima che venisse dichiarato, almeno in parte, incostituzionale.
Ma il “governo del fare”, in questo come in molti altri campi, non ha fatto nulla, dando luogo al vuoto legislativo che oggi si apre e che la stessa Consulta, nella sua sentenza, chiede di riempire al più presto (nella speranza che il Conte 2 faccia un po’ meglio del Conte 1).
Le condizioni poste dalla Corte Costituzionale
Al di là di questa falsa questione formale, resta quella vera, che riguarda la sostanza del problema morale e giuridico.
Perché quel che è certo è che da oggi aiutare una persona a togliersi la vita non è più automaticamente un reato.
Certo, la Corte ha indicato alcune inderogabili condizioni: il proposito di suicidio dev’essere maturato «autonomamente e liberamente», in un soggetto «pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli», e comunque è ritenuto degno di assistenza solo quando questo soggetto è «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili».
Una svolta culturale
Ma si tratta, comunque, di una svolta. Viene superata l’idea, legata alla tradizione cattolica, che la vita sia sacra e non se ne possa disporre.
È su questo che si capisce la portata del contrasto tra la CEI e quella vasta area dell’opinione pubblica che da tempo – al di là degli schieramenti di “destra” e di “sinistra” – auspica un allineamento del nostro Paese ad altri, come il Belgio e l’Olanda, molto più liberali in campo biomedico.
La battaglia, insomma, è culturale. E le parole di Marco Cappato, che vede in questa sentenza – e nella legislazione che inevitabilmente dovrà tenerne conto – un trionfo della libertà, colgono perfettamente nel segno: il problema di fondo, al di là dei singoli casi drammatici, è il modo in cui un ordinamento giuridico concepisce la libertà dei cittadini.
Al di là dei casi personali, il significato di una legge
Non voglio con questo minimizzare il dramma di persone che non se la sentono più di vivere una vita di dolore, di dipendenza totale dagli altri, di disperazione. Davanti a queste situazioni, le concezioni, i ragionamenti, i discorsi, si rivelano inevitabilmente futili, perfino inopportuni.
Ma le leggi di un Paese devono invece tenerne conto. Perché esse non servono solo a sanare situazioni preesistenti, bensì a influenzare la mentalità e il costume, plasmando così il volto di una società e delle persone che vivono in essa.
Le norme giuridiche, insomma, in quanto rendono lecito o illecito un certo comportamento, hanno anche una funzione educativa.
Aristotele non faceva che dar voce al buon senso quando scriveva che «i legislatori rendono buoni i cittadini creando in loro determinate abitudini» (Etica Nicomachea, 1103 b).
E l’educazione alla libertà è sicuramente uno dei compiti che il legislatore (quello che dovrà riempire il vuoto apertosi con la sentenza della Corte) è tenuto ad assumersi.
La libertà come autodeterminazione…
Ma che cosa è la libertà? Ormai da tempo viviamo immersi in un clima culturale che la identifica senza esitazioni con l’autodeterminazione.
Vi è sicuramente in questo una importante conquista rispetto a epoche passate in cui si era soggetti alla volontà di altri – genitori, autorità politiche e religiose, criteri sociali consolidati – che disponevano della vita di una persona, magari con la pretesa di farlo «per il suo bene». Questo paternalismo è stato fortunatamente superato e non e sentiamo la mancanza.
E il suo collegamento col suicidio
Ma siamo sicuri che la libertà sia solo autodeterminazione e non contenga altri aspetti in grado di controbilanciare questo concetto?
Perché, se davvero fosse così, il suicidio sarebbe una perfetta espressione di libertà. Lo evidenzia Dostoevskij nel suo grande romanzo «I Demoni», mettendo in scena il personaggio di Kirillov che preannuncia il proprio suicidio come prova della propria piena libertà.
Lo sfondo di questo proposito è religioso: Kirillov vuole dimostrare che Dio non esiste compiendo un atto che lo svincola totalmente da ogni dipendenza da un preteso Assoluto.
Esiste una missione di cui rispondere?
Un fondamento che anche oggi viene adombrato quando si contrappone l’accettazione della vita – con tutti i suoi travagli – come missione, affidata a un essere umano dal suo Creatore (e alla missione non ci si può sottrarre), a una prospettiva “laica” che la riporta interamente alle preferenze e alle scelte dell’individuo.
Una missione non è in contrasto con il concetto di libertà/autodeterminazione, ma lo collega inscindibilmente a quello di responsabilità – verso gli uomini, se anche non si crede in Dio.
Se invece non c’è alcuna missione, non si deve rispondere a nessuno.
O la dignità consiste nel non dover rispondere a nessuno?
È a questa seconda visione – oggi largamente prevalente – che, già durante il dibattito sul testamento biologico, si ispirava una intelligente esponente della cultura “laica”, Michela Marzano, quando scriveva: «Sono anni che il fronte del “no” invoca il concetto di “sacralità della vita”, facendo finta di non sapere che la dignità di ognuno di noi si fonda sulla nostra autonomia, e che nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri» («La Repubblica», 27 febbraio 2017).
Quelli che non hanno atteso la sentenza della Corte per suicidarsi
La scelta tra l’una e l’altra concezione è decisiva per valutare se il suicidio è di per sé un modo per esprimere la propria libertà. Non ho alcuna pretesa di risolvere sommariamente la questione e rispetto coloro che la pensano diversamente da me.
Vorrei però far presente a chi esulta per questa “licenza di suicidarsi” (in realtà “di assistere” chi vuole farlo), che, a rigore, di motivi di esultanza, di fronte a questo modo esprimere la propria libertà ne aveva già prima della sentenza della Consulta.
In Italia, infatti, ogni anno, scelgono di suicidarsi circa quattromila persone – 3.825 nel 2016 (ultimo dato ufficiale) – che non hanno atteso, per questo, di essere assistiti, tanto meno una svolta legislativa che lo consentisse.
Il suicidio come supremo atto di libertà?
Si potrà obiettare che in simili casi non ci sono le drammatiche condizioni di salute che spingono molti a ricorrere al suicidio assistito. Ma chi decide questo? Chi decide che solo delle malattie accertate possono rendere insopportabile la vita?
Il concetto di libertà come pura e semplice autodeterminazione non consente deleghe. È ancora Michela Marzano che lo scrive, con perfetta coerenza, polemizzando contro il ruolo assegnato ai medici nella legge sul testamento biologico: «Dovevo essere io a decidere. Io paziente, io che soffro e chiedo solo di andarmene via, io che ho diritto di restare fino alla fine soggetto della mia vita. E invece niente. Alla fine, l’ultima parola spetterà ancora ai medici» («La Repubblica» del 20 marzo 2017).
Punire chi ostacola la libera scelta di un suicida?
Se la si prende sul serio, la libertà a cui si riferiscono i tantissimi fautori del suicidio assistito esigerebbe, a rigore, che, per legge, non solo fossero aiutati a morire coloro che lo vogliono, ma fossero puniti (almeno con multe, se non con pene detentive) coloro che cercano di impedire a un suicida di realizzare la sua scelta di libertà.
Perché la solita motivazione che si porta in questi casi – «era un momento, gli passerà e poi mi ringrazierà» – è comunque un’ipotesi: non abbiamo il diritto di giudicare perché l’altro vuole uccidersi.
Per di più, questa motivazione potrebbe applicarsi anche ai casi di persone in preda a gravissime sofferenze fisiche (a maggior ragione se si tratta di quelle psichiche), che, per un imprevisto mutamento della loro situazione esistenziale, scoprissero di avere voglia di vivere, malgrado il dolore.
Ce ne sono tanti che portano la croce di una grave sofferenza perché sanno di essere utili ad altri!
Coniugare autodeterminazione e responsabilità
Queste riflessioni non intendono demonizzare niente e nessuno, ma solo dare un contributo al dibattito pubblico che dovrebbe ora svilupparsi e portare a fare, finalmente, una legge adeguata.
Penso che coniugare, all’interno del concetto di libertà, autodeterminazione e responsabilità, possa servirci oggi, al di là del problema del suicidio assistito, a rileggere criticamente il costume della nostra società e forse a cambiarlo. È una speranza a cui non so rinunciare.