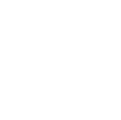«Con tutto il rispetto possibile per il pastore di anime, anziché favorire l’arrivo in Europa dei poveri di tutta l’Africa, il mio dovere al governo è pensare prima ai milioni di poveri italiani. Sbaglio?». Con queste parole, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha replicato su twitter al discorso rivolto alla città dal vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice, in occasione del “festino” di s. Rosalia.
«Con tutto il rispetto possibile per il pastore di anime, anziché favorire l’arrivo in Europa dei poveri di tutta l’Africa, il mio dovere al governo è pensare prima ai milioni di poveri italiani. Sbaglio?». Con queste parole, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha replicato su twitter al discorso rivolto alla città dal vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice, in occasione del “festino” di s. Rosalia.
Il messaggio del ministro sostanzialmente riproduce lo slogan ripetuto innumerevoli volte in questi mesi campagna elettorale e di governo: «Prima gli italiani». Ciò che è nuovo è il contesto: la risposta al pronunciamento ufficiale di un vescovo della Chiesa cattolica che, nell’esercizio del suo ministero, ha preso una posizione fortemente critica nei confronti della politica del governo riguardo ai migranti (come del resto, due giorni dopo, la presidenza ella Conferenza Episcopale Italiana).
Non è una novità di poco conto. Era preclusa a Salvini la via più semplice, che sarebbe stata quella di rivendicare l’autonomia della politica dalla religione. Il suo solenne giuramento di seguire il Vangelo, nel comizio conclusivo della sua campagna elettorale, lo costringeva, infatti, a difendere la correttezza della sua posizione proprio dal punto di vista cristiano. E, su questo piano, le riserve di un pastore della Chiesa suonano sicuramente più preoccupanti, per il titolare del Viminale, di quelle di un Saviano. Da qui il tono del twitter, più rispettoso che tanti altri casi, con l’appello al proprio «dovere» e l’interrogativo finale, che pone la questione in termini etici («Sbaglio?»).
Chi ha letto il discorso di Lorefice, tuttavia, non può non notare che la risposta ne semplifica molto il contenuto, fino a falsarlo radicalmente. Ciò che il vescovo chiede ai palermitani (e, potenzialmente, a tutti gli italiani e gli europei) non è affatto di «favorire l’arrivo in Europa dei poveri di tutta l’Africa» – è ovvio che ridurlo a questo significa renderlo assurdo! –, ma di riflettere sul modo migliore di custodire la propria identità e di fare i propri interessi. «Un’illusione pericolosa si sta diffondendo: che la chiusura, lo stare serrati, la contrapposizione all’altro siano una soluzione, siano la soluzione. Ma una civiltà che si fondi sul “mors tua, vita mea”, una civiltà in cui sia normale che qualcuno viva perché un altro muore, è una civiltà che si avvia alla fine. È questo che vogliamo?».
Era questa la domanda a cui Salvini doveva rispondere. Una domanda che investe l’atteggiamento di fondo, lo spirito con cui la nostra società si deve porre di fronte ai migranti. Perché, sulle modalità concrete di conciliare le loro esigenze con quelle degli italiani e in genere degli europei, è giusto che sia la politica a prendere le sue decisioni. Ma è l’orizzonte in cui esse si collocano che può risultare molto diverso a seconda che si ispirino oppure no a un valore non solo cristiano, ma anche semplicemente laico come la «fraternità» (vi ricordate il motto della rivoluzione francese? «Liberté, égalité, fraternité»).
È questo valore che evita al primo – la libertà – di diventare irresponsabilità, e al secondo – l’uguaglianza – di misconoscere la ricchezza della diversità. I fratelli possono avere personalità e storie molto differenti, come le hanno africani e asiatici rispetto agli europei, ma – ha ricordato il vescovo Lorefice – «la fraternità significa che siamo tutti figli, tutti sullo stesso piano, responsabili gli uni degli altri, legati reciprocamente con un vincolo inscindibile». Quali che siano le misure concrete da prendere, siamo noi oggi nell’otica della fraternità?
Era questa la domanda a cui Salvini doveva rispondere. E in fondo l’ha fatto. Perché, nel suo linguaggio – che è quello oggi diffuso tra tutti i sovranisti non solo dell’Europa, ma del mondo –, «prima gli italiani» significa che degli altri non ci possiamo preoccupare. Il ministro l’ha detto chiaramente quando gli chiesero che ne sarebbe stata dei 660 profughi imbarcati sull’Aquarius: «Sono affari loro».
Diciamo la verità: non è solo Salvini a pensarla così. È ormai sotto gli occhi di tutti che cosa voglia dire, in bocca a Donald Trump, «Prima l’America». Oggi i commentatori si trovano a prendere atto della disintegrazione traumatica, sotto i colpi del presidente degli Stati Uniti, di quella comunità culturale, politica ed economica che era l’Occidente. «Prima l’America» significa, in realtà, «peggio per gli altri», specialmente se sono deboli.
E, sempre a livello extra-europeo, proprio in questi giorni il parlamento israeliano ha approvato una legge che dice che lo Stato d’Israele è «del popolo ebraico», non – come era stato fino ad ora – di coloro che vivono in esso e che ne hanno la cittadinanza. In questo modo tutti i cittadini arabi di questo Stato sono diventati, automaticamente, di serie B; l’arabo non è più una delle due lingue ufficiali del Paese; si apre un regime di apartheid e di discriminazione. «Prima gli ebrei».
E se passiamo all’Europa, i Paesi del gruppo di Visegrad – Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria –, a cui fanno esplicitamente riferimento gli altri Stati sovranisti – in qualche modo l’Inghilterra, dopo la Brexit, l’Austria e, sia pure con delle oscillazioni, l’Italia – si basano sullo stesso motto: «Prima i nostri cittadini». Per questo la loro linea non è affatto (come qualcuno cerca di far credere) di consentire una equa distribuzione degli immigrati in tutta Europa. Essi hanno esplicitamente rifiutato le quote loro assegnate da Bruxelles (proprio questi giorni l’Ungheria di Orban, nella cui linea il nostro ministro degli Interni si riconosce, è stata deferita alla Corte di giustizia europea per aver violato sistematicamente le regole sull’asilo dei profughi).
Per questo, in Italia, l’obiettivo dello stesso Salvini non è – a differenza di quello del premier Conte, che lavora con alterna fortuna e quasi di nascosto per tale obiettivo – di ottenere finalmente una equa distribuzione dei profughi tra i diversi Stati europei, ma di rimandarli in Libia, contraddicendo il parere unanime dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati e dell’Unione Europea, secondo cui in questo Paese non c’è alcuna garanzia del rispetto dei diritti umani (e ci sono anzi delle provate violazioni di essi). Con la “giustificazione”, dal punto di vista morale, che in questo modo non annegheranno più nel Mediterraneo (perché – bisognerebbe aggiungere – moriranno nei lager libici…).
Opporsi allo slogan «prima noi» è “buonismo”? Le conseguenze della dissoluzione dell’Occidente e della crisi dell’Unione Europea, anche sui Paesi che la stanno provocando (si pensi all’Inghilterra), dovrebbero essere sufficienti a dimostrare la verità delle parole del vescovo di Palermo: il vero interesse di una comunità non sta nel ripiegarsi egoisticamente su stessa. Certo, la distinzione tra chi ne fa parte e chi si trova all’esterno di essa è legittima; ma non può significare l’esclusione e la discriminazione degli “altri” che il triste slogan «prima noi» comporta.
In ogni caso, poiché Salvini, per assicurarsi i voti dei cattolici, ha voluto giurare sul Vangelo, che si prenda il disturbo, una buona volta, di leggerlo. O almeno di lasciarsi istruire da chi, come il vescovo Lorefice, lo conosce: «È in nome del Vangelo che ogni uomo e ogni donna hanno diritto alla vita e alla felicità, perché “non c’è più giudeo né greco, non c’è più schiavo né libero in Cristo Gesù” (Gal 3,28)». Non ci si trova scritto, infatti, che il samaritano, al giudeo ferito dai briganti, abbia detto: «Mi dispiace, prima i samaritani». Oppure: «Io sono samaritano; voi giudei dovete risolvere il problema a casa vostra, sradicando il brigantaggio».
Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca (vv.33-34) si dice: «Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui». Come stanno facendo tutti quei marittimi – militari e civili – che, contravvenendo agli ordini severissimi del “capitano” Salvini, obbediscono ancora al comando cristiano di salvare dalla morte chi sta annegando, non perché sia cittadino italiano, ma perché è un uomo.