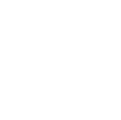Mons. Corrado Lorefice
Arcivescovo di Palermo

Un caro simpatico saluto a tutti a voi qui presenti e a quanti ci seguono in diretta streaming. Il tema che mi è stato affidato è «Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle diseguaglianze sociali». Sono contento di stare qui con voi, di ascoltare le vostre eventuali domande, su problematiche che voi ragazzi e ragazze sentite forse più di tutti e di tutte.
La Chiesa di papa Francesco? Cosa vogliono dire coloro che hanno pensato questo titolo, che ringrazio per l’invito? Cosa caratterizza la Chiesa che papa Francesco cerca di sognare, di costruire? Lo possiamo forse comprendere se consideriamo che il suo primo viaggio fu a Lampedusa (8 luglio 2013). A Lampedusa, noi lo sappiamo, approdano ormai da alcuni decenni migliaia di profughi, di persone che la vita ha reso non-persone, ha reso «scarti», «rifiutati» della terra.
Il Papa veniva da un altro continente, veniva dall’Argentina. Era stato da poco eletto vescovo di Roma e sentì parlare dei barconi che affondano. Sentì parlare di quel cimitero che stava diventando il Mediterraneo: dove donne, bambini, giovani come voi perdono la vita, annegando. Quei ragazzi e quelle ragazze, quei bambini, hanno i sogni che avete voi, hanno cuore e aspirazioni che avete voi. Andando a Lampedusa, papa Francesco ha indicato alla Chiesa una chiara rotta: quella di partire dagli esclusi, dai più poveri, dagli scartati della società. Recandosi a Lampedusa Francesco ha voluto dare un segnale: la Chiesa sta dalla loro parte! Annuncia il Vangelo, la Bella Notizia, a partire dalla discriminazione e dalle ingiustizie.
Lì, in quel porto aperto di Lampedusa, il Papa è andato, certo, per pregare ma anche per risvegliare le coscienze di tutti. In quel primo viaggio il Papa ha posto una domanda al mondo, una domanda che Dio continua a porre a ciascuno di noi: «Caino, dov’è tuo fratello?». Perché è chiaro a tutti e tutte noi che se ci sono gli scartati della terra ciò non è frutto del caso, non è frutto di un destino cieco. È frutto di un sistema che abbiamo costruito: un sistema economico, finanziario e politico che, per alimentarsi, per continuare a vivere nei suoi lussi, ha bisogno che una parte della famiglia umana sia scartata: quella che chiamiamo Sud del mondo, che chiamiamo Africa, Medio Oriente.
In effetti, se ci pensiamo bene, siamo dentro ad un sistema strutturale di peccato costruito da nuovi “Erode” per difendere il proprio benessere. Siamo una società chiusa in se stessa che, per riprendere le parole di papa Francesco «ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!» (Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013).
Guardando il mondo di oggi, domandiamoci con Francesco: «Chi governa allora? Il denaro? Come governa? Con la frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare che genera sempre più violenza» (Discorso per il Terzo incontro dei movimenti popolari, Vaticano, 5 novembre 2016). Il denaro è l’idolo davanti al cui altare si immola tutto e tutti.
Ma tutto ciò su cosa è fondato? Siamo in una “dittatura” del denaro fondata sulla paura. I signori del denaro ci mettono paura per alimentare i loro affari. La nostra paura viene alimentata, viene manipolata, attraverso i mass media. I fabbricanti di armi, di morte e di profitti facili alimentano la nostra paura perché sanno che la paura «ci indebolisce, ci destabilizza, distrugge le nostre difese psicologiche e spirituali, ci anestetizza di fronte alla sofferenza degli altri e alla fine ci rende crudeli», indifferenti verso gli altri (Discorso per il Terzo incontro dei movimenti popolari, Vaticano, 5 novembre 2016).
È in questo contesto che ritorna la domanda: «Caino, dov’è tuo fratello?», una domanda che ci interpella tutti e tutte. E interpella anche la Chiesa, la mia Chiesa: con le sue responsabilità. Dunque, qual è la Chiesa che papa Francesco sta cercando di disegnare? È una Chiesa che vuole partire dalla realtà. È una Chiesa «in uscita» dalle proprie mura. Non una Chiesa che dall’alto delle sue sicurezze annuncia la sua verità, ma una Chiesa che percepisce che può essere credibile nel suo annuncio del Vangelo di Gesù di Nazaret se esce dalle sagrestie e sta sulla strada. Lì, sulla strada, dove vi è il dolore del mondo, lì dove stanno gli scartati della terra, dove stanno le vittime delle ingiustizie.
Questa è la Chiesa che anche io, nel mio piccolo, cerco giorno dopo giorno, che desidero che diventi sempre più visibile concretamente anche a Palermo, nella nostra Città, nella vostra Città, cari ragazzi e care ragazze. La nostra città che dobbiamo insieme riscattare da tutto quello che la schiavizza e non le permette di prendere il largo.
Partire dalla realtà, partire dagli esclusi, dalle vittime, non è una novità, un pallino di papa Francesco. È quello che fece Gesù: dall’accogliere i lebbrosi, allora esclusi dalla città, fino alla frequentazione delle donne, allora molto emarginate dalla società, e dei pubblici peccatori. Per meglio spiegare questo suo progetto, di un mondo diverso, di un mondo migliore, che con un linguaggio biblico antico chiamiamo “regno di Dio”, Gesù narrò la parabola del ‘buon samaritano’ (cfr Lc 10, 25-37). Forse la ricorderete. Di quell’uomo che i briganti avevano rapinato lasciandolo sul ciglio della strada mezzo morto. Tanti passavano nell’indifferenza. In quella parabola, Gesù annota che anche un sacerdote passò da quella strada senza fare nulla per il malcapitato, continuando ad andare per la propria strada verso il tempio. Gesù non lodò quel sacerdote che se ne andava a svolgere le sue pratiche religiose, nell’indifferenza verso chi stava su un ciglio di strada. Gesù indicò come esempio un samaritano: cioè uno straniero – un eretico per i giudei – che, passando e vedendo la concreta sofferenza umana, scese da cavallo e si prese cura di quella vittima. Le vittime, gli scartati della terra non sono cosa di altri. Sono volti, mani, dolore, che ci riguardano, che ci chiamano alla responsabilità!
Ma chi sono i nuovi “buoni samaritani” in terra di mafia che scendono da cavallo, dal loro mondo privato, per piegarsi sulle ferite di una terra violentata dal sistema del potere mafioso? Voi lo sapete. Sono sindacalisti come Salvatore Carnevale, sindacalista della CGIL, che a Sciara (piccolo centro dell’entroterra palermitano) difendeva le cause dei braccianti, dei “jurnatara”, dalla mafia dei gabelloti e dei latifondisti e che per questo fu ucciso proprio dalla mafia il 16 maggio 1955.
Chi sono oggi i “buoni samaritani”? Sono giovani, appena un po’ più grandi di voi, come Peppino Impastato che dalla sua “Radio Out” denunciava la mafia di Cinisi. Avrete tutti certamente visto il film “Cento passi” che narra la vicenda di Peppino. Da questo giovane coraggioso, non interessa se era credente o meno, tutti dobbiamo imparare a compiere i nostri cento passi di responsabilità: di assumerci le nostre responsabilità. Come diceva il cardinale Carlo Maria Martini: «Ciò che conta è essere credibili» (Cfr. C. M. Martini – R. Williams, Essere cristiani credibili, Edizioni Qiqajon, 2013). Mi colpisce il fatto che Peppino, nella sua lotta, era quasi solo, a mani nude, senza appoggi, con pochi altri ragazzi. Gli uomini veramente liberi non attendono che si muovano prima gli altri, per agire. Nella nostra società siamo portati a scaricare le responsabilità sugli altri. Anche Gesù di Nazaret, quando scacciò i mercanti dal tempio, era solo. Sapeva di rischiare, sapeva bene che quel gesto profetico ne avrebbe preparato la morte. Eppure andò per la sua strada! Quello che possiamo fare noi facciamolo, senza attendere che gli altri facciano ciò che è giusto. Gesù si prende le sue responsabilità. La spirito profetico, lo Spirito del Padre, lo spinse ad agire. La sua “ora”, così come la nostra “ora”, è in ogni momento: è qui ed è ora, non domani!
Chi sono dunque oggi i nuovi “Buoni samaritani”? Sono uomini generosi come il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato in Sicilia, dopo l’omicidio di Pio La Torre. Fu inviato da Roma a Palermo, ma senza poteri reali per schiantarsi contro “il potere” mafioso. Il cardinale Salvatore Pappalardo, mio predecessore come vescovo di Palermo, nell’omelia per i funerali del generale nell’affollata Chiesa di San Domenico disse: «Dobbiamo prendere sempre più coscienza, ognuno per la parte di responsabilità che lo riguarda, di quanto presenti, forti e tracotanti siano le forze del male che operano nella nostra società, per tutelare e difendere i loschi interessi di potenti fazioni, variamente denominate» (Da questa nostra isola. Discorsi e omelie, prefazione di Bartolomeo Sorge, Mondadori, 1986, 50-52). Cosa voleva dire Pappalardo quando parlava di «potenti fazioni» e di «loschi interessi»? Io non lo so. Ma posso ben pensare che aveva in mente che la mafia che ha mortificato e mortifica la nostra terra e il nostro Paese non è solo quelle della manovalanza. Ma che la mafia è costituita da «potenti fazioni» e da «loschi interessi» anche di natura economica, finanziaria e politica. Il potere mafioso, non possiamo essere ingenui, non è solo una questione di comune criminalità organizzata. La mafia dalla quale dobbiamo liberare la nostra terra è la mafia legata a quei membri delle classi dirigenti che fanno della corruzione lo strumento per conservare i propri privilegi. Quella è il potere mafioso, non vorrei sbagliare, al quale pensava anche Giovanni Falcone quando parlava di «menti raffinatissime».
La corruzione, denunciata continuamente da papa Francesco, non è estranea a tutto ciò. E la corruzione non è qualcosa di episodico. Essa è figlia di un sistema raffinatissimo. Si tratta di qualcosa di sistemico, non di qualche evento eccezionale. Anche le leggi a volte possono essere pensate e redatte proprio per alimentare un sistema di interessi, di corruzione, sfruttando i bisogni della gente e le risorse pubbliche a fini privati.
Di fronte a questa realtà dobbiamo scendere da cavallo, dal nostro privato, dalle nostre sacrestie, uscire dai nostri recinti di sicurezza effimera e impegnarci, insieme, in un rinnovato processo di liberazione.
Voi giovani amate la sincerità e la trasparenza. Non posso finire questo mio breve intervento, senza riconoscere che non sempre, nel passato, la Chiesa cattolica sia uscita dalle proprie sacrestie. Non sempre e non tutta la comunità ecclesiale, senza generalizzazioni che non aiutano a capire davvero la storia, ha saputo scendere da cavallo per esercitare un ministero di liberazione dal peccato mafioso e dal sistema di corruzione. Forse dobbiamo chiedere perdono per quando come Chiesa non abbiamo fatto quanto dovevamo: quando siamo stati omissivi o in silenzio. Quando abbiamo annunciato i valori evangeli in forma astratta, senza annunciarli (nelle omelie o nelle catechesi) a partire dalla realtà della nostra terra violentata dalla mafia, a partire dalle vittime.
Ma se io, come vescovo, oggi sono qui, se sono qui a condividere con voi speranze e sogni di cambiamento; se sono qui con voi per guardare in avanti, per guardare ad una Sicilia liberata dal potere mafioso; se oggi sono qui con voi a desiderare un futuro di pace, di giustizia, di dignità per tutti e per tutte, delle donne in particolare perché spesso le più maltrattate e violate, allora vuol dire che la Chiesa che papa Francesco cerca di testimoniare sta camminando, sta prendendo forma.
Se sono qui con voi lo devo, anche, alla testimonianza e all’insegnamento di due preti e di un giovane magistrato del nostro Sud. Lo devo a don Pino Puglisi, ucciso a 56 anni dalla mafia a Brancaccio, ormai quasi 25 anni fa. Il Signore mi ha dato la grazia di conoscerlo e di condividere con lui meravigliose esperienze in favore dei giovani. Oggi per la chiesa è Un Beato, martire in odium fidei. La chiesa riconoscendo il suo martirio ha dichiarato la mafia costitutivamente antievangelica.
Se sono qui lo devo anche a don Peppe Diana, ucciso a 36 anni dalla camorra a Casal di Principe (Caserta) quasi 24 anni fa. Di don Diana papa Francesco in una pubblica manifestazione per la Giornata della memoria per le vittime della mafia di qualche anno fa (21 marzo 2014) ha voluto indossare la stola sacerdotale. Con quel gesto il Papa ha voluto dire: è questa la strada che dobbiamo scegliere come Chiesa: quella di don Puglisi e di don Diana.
Lo devo anche a Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia a 38 anni il 21 settembre del 1990, per cui c’è in corso l’iter per la beatificazione. Secondo la sentenza di condanna degli esecutori e dei mandanti del suo omicidio, Livatino è stato assassinato poiché «perseguiva le cosche mafiose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l’espansione della mafia». Rosario non faceva mistero di una radicata fede cristiana, che armonizzava rigorosamente con la laicità della propria professione. Lo rivela un suo scritto dei primi anni Ottanta che riprende il tema del rapporto tra fede e diritto: «Il compito […] del magistrato è quello di decidere; […]: una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. […] Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale. Entrambi, però, credente e non credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia» (E. Chiari, Storia di Rosario Livatino, il giudice ragazzino, in http://www.famigliacristiana.it/articolo/storia-di-rosario-livatino-il-giudice-ragazzino.aspx). La sua fede è testimoniata nella sigla trovata in fondo alle sue agende, “s.t.d.”: il significato è sub tutela Dei, nelle mani di Dio, sotto la protezione di Dio.
Da don Puglisi, da don Diana, dal giudice Livatino, dunque, ho ricevuto la testimonianza che una Chiesa profetica, una Chiesa libera e liberatrice è possibile. Da loro ho ricevuto l’insegnamento che la Chiesa si può permettere di essere profetica e liberatrice nella misura in cui è una Chiesa povera, che non cerca appoggi, che non cerca privilegi dalle classi dirigenti. Che vive sulle strade degli uomini e delle donne di oggi confidando solo nella potenza della debolezza esaltante del Vangelo di Gesù Cristo.
Vorrei concludere questo incontro (per poi magari rispondere alla vostre domande) proprio ricordando due frasi di don Pino Puglisi: «A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola: è una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’uomo per soldi». E ancora: «Venti, sessanta, cento anni… la vita. A che serve se sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare Cristo, vivere come lui, annunciare il suo Amore che salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al proprio posto, anche pagando di persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo» (Cit. in C. Lorefice, La compagnia del Vangelo. Discorsi e idee di don Pino Puglisi a Palermo, San Lorenzo, 2014).
Vi ringrazio per avermi ascoltato.