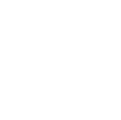Se c’è un punto della dottrina cristiana che sembra avere perduto ogni significato, nella coscienza dell’Occidente, è quello che riguarda il Paradiso. Oggi nessuno ne parla più. Neppure i preti durante le omelie. E dire che per secoli la speranza nel compimento eterno, costituito da un’altra vita, più bella e più felice di quella che viviamo nel tempo, è stata alla base della devozione non solo delle masse, ma anche degli intellettuali. E con un buon fondamento nella Sacra Scrittura: «Oggi sarai con me in Paradiso», dice Gesù, sulla croce, al buon ladrone. E ancora: «Io ritengo», scrive san Paolo ai Romani, «che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere manifestata in noi». Nel nostro tempo, in realtà, non se ne parla più. Gli stessi “cristiani praticanti” intendono la loro fede come un impegno da vivere su questa terra, come una stagione fine a se stessa, non come una preparazione a quella futura.
Se c’è un punto della dottrina cristiana che sembra avere perduto ogni significato, nella coscienza dell’Occidente, è quello che riguarda il Paradiso. Oggi nessuno ne parla più. Neppure i preti durante le omelie. E dire che per secoli la speranza nel compimento eterno, costituito da un’altra vita, più bella e più felice di quella che viviamo nel tempo, è stata alla base della devozione non solo delle masse, ma anche degli intellettuali. E con un buon fondamento nella Sacra Scrittura: «Oggi sarai con me in Paradiso», dice Gesù, sulla croce, al buon ladrone. E ancora: «Io ritengo», scrive san Paolo ai Romani, «che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere manifestata in noi». Nel nostro tempo, in realtà, non se ne parla più. Gli stessi “cristiani praticanti” intendono la loro fede come un impegno da vivere su questa terra, come una stagione fine a se stessa, non come una preparazione a quella futura.
Le ragioni di questo oblio sono tante. Una è la giusta reazione a una prospettiva, quella del passato, che era oggettivamente unilaterale e riduttiva. La nostra presenza in questo mondo non può essere svalutata come un puro “esilio”. Il Vangelo presenta la vita eterna come qualcosa che deve cominciare già su questa terra, anche se dovrà aver la sua pienezza dopo la nostra morte fisica. Un certo tipo di spiritualità aveva fatto dimenticare questa continuità e ridotto il cristianesimo a un’attesa del futuro, misconoscendone le implicazioni nel presente. In questo giocava una scarsa valorizzazione del mondo così com’è, nella sua materialità. Lo spirito – l’anima – veniva contrapposto al corpo e si pensava che solo liberandosi di esso avrebbe avuto la sua più vera libertà.
Da qui la denunzia – tutt’altro che infondata – di una religiosità che, in nome del Paradiso, da un lato esonerava i credenti dalla coerenza cristiana e dalle responsabilità terrene, magari rimandandoli a un pentimento in articulo mortis, dall’altro illudeva i poveri, spingendoli ad accettare lo sfruttamento e la miseria della loro vita quaggiù in nome della promessa di una felicità in quella lassù. È in questo senso che Marx definisce la religione «oppio dei popoli» e stigmatizza il modo in cui è stata spesso strumentalizzata dalle classi dominanti per tenere a bada quelle subalterne.
Ma veramente il Paradiso si può ridurre a questa proiezione, di sicuro alienante, a livello sia personale che sociale? Per rispondere a questo interrogativo forse può essere utile porne un altro, preliminare: veramente si può considerare la vita che conduciamo nell’arco della nostra esistenza terrena come pienamente significativa, se non c’è nient’altro dopo la nostra morte? Che valore hanno le cose che facciamo, la stessa identità che ci costruiamo, se poi tutto ciò è destinato a cadere nel nulla?
Mi è capitato spesso di parlare di questo con persone, per lo più non credenti, ma qualcuna anche credente, che rispondevano positivamente a questa domanda. Per quanto riguarda le prime, un argomento fondamentale è che non dobbiamo chiedere alla nostra vicenda umana più di quanto l’ordine naturale conceda a tutti gli altri esseri viventi: nascita, atto riproduttivo, decesso. Gli individui sono funzionali alla sopravvivenza della specie. La loro morte è normale.
Ma possiamo considerare esauriente questa descrizione, alla luce di una civiltà come la nostra, che ha celebrato il valore unico e irripetibile del singolo? Più significativa è l’altra argomentazione, secondo cui alla fine il vero modo di sopravvivere, per un individuo, è di rimanere nel ricordo degli altri. Anche questo, però, può essere di conforto mentre si è vivi, ma – se la morte implica l’annullamento del soggetto – non ha per lui nessuna importanza quando cessa di esserlo.
La grande ombra della vanità incombe, allora, su tutta l’esistenza. È vero che nell’antichità Epicuro ha detto che non dobbiamo preoccuparci della morte perché, finché siamo vivi, essa non c’è, e quando si verifica non ci siamo noi. Ma, soprattutto nella filosofia contemporanea, si è sempre più chiaramente percepito che la morte non è la fine della vita, ma ne mette in discussione tutto lo svolgimento, condannandolo al non senso del nulla eterno. E così è del resto a livello psicologico: a differenza di quanto accade agli animali, gli esseri umani sono capaci di anticipare la propria fine, molto prima che avvenga, con uno stato d’animo che gli esistenzialisti hanno chiama “angoscia”.
Anche molti credenti non sembrano dedicare al tema dell’altra vita, e quindi del Paradiso, una particolare attenzione. Anzi rigettano con un leggero disgusto l’idea che si possa essere fedeli a Dio e ai fratelli in vista di una ricompensa celeste. Sarebbe – osservano, non senza ragione – una fede utilitarista che nulla ha a che fare col Vangelo. Da qui il grade silenzio che è calato, anche nelle nostre chiese, sull’al di là.
Dove forse si potrebbe obiettare che l’idea del premio è viziata dal suo carattere estrinseco, rispetto alla vita buona condotta sulla terra, ma si potrebbe forse recuperare se si concepisse la pienezza futura come lo sbocco spontaneo di questa vita buona. Diceva don Barsotti che per il cristiano la morte non esiste. Egli continua a vivere con Dio come viveva già sulla terra, solo che lo fa con maggiore pienezza. Perché, se tutto finisse con la morte, anche il nostro rapporto con Dio e con Cristo finirebbe. Cosa perfettamente plausibile dal lato dell’uomo, che è sempre mutevole, ma non di Dio, il cui amore per ogni singolo essere umano è indefettibile.
Senza dire che, ove non esista il Paradiso, la storia sarebbe inesorabilmente segnata da una tragica ingiustizia che la rende inaccettabile e che i nostri sforzi – anche nell’ipotesi più ottimistica – non potrebbero cancellare. Questi sforzi, infatti riguardano il presente e il futuro, ma non possono più compensare i milioni e milioni di vittime della povertà, della violenza, dell’ingiustizia nel corso dei secoli passati. Possiamo perdonare a Dio di avere permesso tutto questo solo se alla fine Egli «asciugherà ogni lacrima» dai volti di questi nostri fratelli e sorelle, come dicono Isaia e l’Apocalisse. Altrimenti, non solo dovremmo dubitare di Lui, ma neanche noi avremmo il diritto di essere felici, come se nulla fosse.
Certo, per credere nel Paradiso ci vuole un atto di fede che va al di là delle ragioni che ho portato. Ma per non crederci – come fanno tanti oggi – bisogna chiudere gli occhi sui problemi che ho posto. In ogni caso, forse sarebbe più logico almeno ricominciare a parlarne.